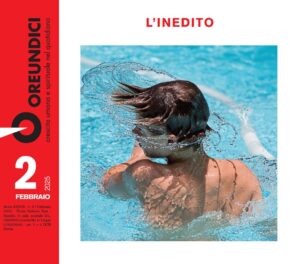
La guerra appare ancora più assurda
c’è un grande bisogno di riflessione, di pacatezza, di senso della complessità
Il testo di DON CARLO MOLARI che proponiamo è tratto da un suo piccolo libro intitolato ‘Aperti all’inedito. A colloquio con don Carlo Molari’, edito nel 1998 dalle Edizioni Lavoro, pubblicato in occasione del congresso della Fim-Cisl a Genova nel 1997.
Di fronte ai processi vitali siamo assolutamente inadeguati come individui, in tutti gli ambiti. Siamo chiamati assieme agli altri a creare spazi di irruzione del futuro, delle nuove qualità vitali che debbono emergere: spazi creativi, spazi “materni” potremmo dire.
La gente comune può vivere certamente in questo orizzonte, con la consapevolezza di essere, in un intreccio di rapporti, una tessera di un grande processo che è molto più ampio, del quale siamo sì una componente, ma collegata a tante altre. E questo vale tanto più per coloro che portano una responsabilità sociale.
Ma è una responsabilità, un potere di guida che diventa sempre più distribuito. Non esiste più il re o il principe, cioè la persona chiamata da Dio a essere depositaria di un potere unico. Il potere emerge dalle forze della vita e viene distribuito nella molteplicità dei carismi, per usare una parola che a noi è consueta e che indica l’espressione di potenzialità e caratteristiche molteplici nella diversità delle persone. In fondo sta qui il senso della democrazia, nella valorizzazione di tutte le espressioni che la vita assume nel tempo e nello spazio.
Questa frammentarietà nella distribuzione dei carismi, e dunque delle funzioni, si esprime anche nel tempo. È definitivamente tramontata la concezione di un potere assoluto che deve rimanere fermo e indiscusso perché donato da Dio, come in antico era attribuito a re e imperatori. Il carisma è soggetto come ogni altra cosa umana alla successione, è dato per un determinato periodo. Non è questa una delle leggi fondamentali della democrazia? Uno ha dato il suo contributo allo sviluppo della società e della storia e poi, esaurito il suo mandato, deve mettersi da parte. Se è capace di fare una determinata cosa un certo giorno, non è detto che lo sia anche il giorno dopo. Perché noi siamo semplici ambiti dove la vita si esprime ed essa offre qualità in vista di particolari funzioni e circostanze. Noi non possediamo la vita, ma la accogliamo.
Qui è fondamentale il concetto di creatura tipico della tradizione cristiana: essere creatura non vuol dire semplicemente essere nati, sorti nel tempo, ma significa dipendere totalmente e compiutamente nella propria realtà da qualcosa che ci investe, ci precede e ci alimenta, anche a livello fisico.
A livello fisico siamo alimentati da un concorso di forze – oggi i fisici parlano di quattro forze fondamentali: nucleare forte, nucleare debole, elettromagnetica e gravitazionale – che vengono dai confini dell’universo e pervadono tutta la realtà. Se venisse meno una di queste forze, noi ci esauriremmo.
Ora, essere consapevoli della condizione di creature equivale a sapere che ciò che noi siamo è dono continuo e che la vita si esprime in noi all’insegna della precarietà e della temporaneità (…)
Proviamo a tornare ai tempi antichi, quando predominava l’idea di un assoluto che permeava di sé anche le istituzioni terrene. Assoluto, ad esempio, era il Sacro Romano Impero perché traduzione, o rispecchiamento sulla terra dell’ordinamento divino; di questa assolutezza era partecipe il codice di diritto romano, che quindi non poteva essere cambiato, ma solo interpretato per adattare in qualche modo la mutevole realtà alle sue immutevoli norme. Di qui l’immane fatica dei glossatori, che riempivano i codici di “note a margine”, appunto le “glosse”, commenti interpretativi che non di rado facevano dire al testo l’opposto di quello che intendeva in origine, nel disperato tentativo di adattare gli enunciati del codice alle situazioni sociali cambiate.
Se nella concezione statica del mondo tutto diventava assoluto perché riflesso dell’assolutezza divina, nella prospettiva dinamica tutto diventa funzionale e contingente, e questa precarietà è connaturata alla nostra condizione. Se quindi la vita ci affida un compito, esso deve essere svolto sapendo che non è eterno, ma soggetto al mutamento dei parametri di riferimento e prima o poi si esaurisce.
Dunque, imparare a vivere la precarietà è essenziale per vivere bene, perché questa è la nostra condizione di creature contingenti. Per dirla in modo provocatorio, non siamo noi a vivere, ma è la Vita che in noi si esprime; non siamo noi ad amare, ma è il Bene che in noi cerca di tradursi; non siamo noi a dire il vero, ma è la Verità che in noi cerca formule, idee, progetti, paradigmi per potersi esprimere e comunicare; non sono i nostri progetti a essere giusti, ma è la Giustizia che in noi cerca di formulare progetti per diffondersi e stabilirsi nel mondo. In una prospettiva dinamica, l’orizzonte della fede, sia essa semplicemente “vitale”, o se volete “laica”, oppure più compiutamente “religiosa”, agevola molto il vivere bene la condizione di precarietà. (…)
Noi non siamo stati educati all’adeguamento, perché usciamo da un mondo in cui anche la religione educava alla fissità, mentale e verbale: le formule devono essere quelle, i gesti gli stessi, sempre ripetuti… Pensiamo ai gesti liturgici e a quanta gente entrata in crisi quando c’è stata la riforma liturgica. Tutto ciò era frutto di una educazione che anche nella modernità inculcava un’idea di fissità.
Anche nella politica l’ideale era realizzare un progetto che avrebbe avuto un compimento e sarebbe rimasto per sempre. Oggi un approccio di questo tipo è impossibile, perché tutto ciò che pensiamo è funzionale, provvisorio, sempre condizionato da determinati modelli. La fine delle certezze non è essere necessariamente e in primo luogo un fattore di angoscia, ma diventa l’inizio di un nuovo modo di vivere e godere la vita, che fa appello alla capacità di coglierla nelle sue offerte quotidiane. (…)
La crisi attuale della società è tutta nella difficoltà di trovare modelli, anche mentali, per vivere la mobilità dei processi, la precarietà della condizione umana. È un problema anche per la chiesa, che vive ugualmente questa crisi di passaggio ai modelli nuovi. In fondo è stato il Concilio Vaticano II – parlo per la Chiesa Cattolica- che ha avviato questo passaggio verso paradigmi mutevoli, in grado di aiutare il cammino attraverso la condizione di precarietà e mutamento. (…).
Non è un cambiamento da poco aprire un percorso educativo all’insegna della mobilità, in una realtà ecclesiale segnata fino a ieri dal primato della fissità. I criteri dell’ortodossia, che significa “retta opinione”, erano dettati da formule tramandate per secoli, che esprimevano mirabilmente una cultura della certezza incrollabile: la verità andava ricercata là dove non c’era margine per l’equivoco.(…)
Ora, dopo secoli nei quali ha dominato un simile modello, impostare un percorso educativo e culturale sintonizzato sul cambiamento è davvero una rivoluzione copernicana. Essa suppone una maturazione spirituale che richiederà un po’ di tempo: è difficile pretendere che una generazione riesca a compiere un passaggio così veloce, è però importante che cresca una consapevolezza del cambiamento profondo che stiamo vivendo, in modo da non lasciarci sopraffare dall’angoscia del cambiamento, sapendo che è un processo necessario. La prima cosa da fare allora, una volta raggiunta questa consapevolezza, è individuare questi segni che indicano il cammino e le opportunità.
Qui ritorno al discorso sulla fede in Dio: il credente ha tutti i motivi per vivere serenamente questa condizione, con gioia e con senso di responsabilità, perché sa che la fonte del bene e della verità c’è ed è piena, e ha fiducia che i nostri progetti, magari ancora intrisi di passato, saranno realizzati, anche se in una forma che non è dato per ora di vedere compiutamente. Noi non siamo ancora capaci di progettare il futuro e dovremmo sempre educarci ad accoglierlo, sintonizzandoci con le dinamiche della vita e della storia.
Da questo punto di vista, dire che «il futuro è opportunità» ha un significato molto più ricco e profondo di quanto si possa immaginare.
Se dobbiamo educarci alla mobilità, allora non ci sono profeti permanenti. Vi sono persone, o gruppi di persone, che possono svolgere funzioni profetiche in un certo periodo, nel successivo altre persone si sostituiranno ad esse. Anche il sindacato, e persino un partito in certi momenti può diventare luogo della profezia. Ma guai pensare che possa esserlo in modo permanente: ciò non corrisponderebbe più all’orizzonte di una cultura caratterizzata dalla percezione della precarietà.
Anche le cose buone sono precarie, e precaria è la bontà delle persone. Non c’è nessuno che possa dire: io sono buono, perché devo cambiare? Buono è semmai chi sa di non esserlo mai pienamente, e perciò è costantemente aperto a nuove e inedite possibilità di vita, che richiedono una continua revisione di sé, della propria cultura, delle proprie certezze.
