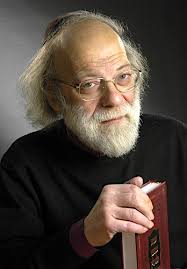
in “Robinson” – la Repubblica – del 21 agosto 2021
È nato a Parigi nel 1947, l’anno prima della fondazione dello Stato d’Israele Di origini polacche, fa lo psicoanalista a Milano. Suo padre fu uno dei pochi a tornare vivo da Auschwitz. “ Il cappello scemo” è il titolo del suo nuovo libro.
Forse nessuno come Haim Baharier sa scendere nelle profondità del Talmud riemergendone con storie solo all’apparenza stravaganti. Ma che cos’è la stravaganza nella cultura ebraica se non appunto lo scudo per proteggersi dalla realtà, una volta che questa riveli il suo lato più ostile? Forse è per questo che parlandomi per telefono, in puro spirito yiddish, Haim mi dice che il modo migliore per avere uno sguardo di insieme del Talmud è provare a lavorare su qualche frammento. Come un frammento di una storia, non priva di risvolti immaginifici, mi appare il titolo del suo nuovo libro: Il cappello scemo.
Cosa c’è di più stravagante di un dettaglio che solo alla fine della storia scopriremo rivelarsi nientemeno alla base della fondazione di Israele? Haim Baharier è nato a Parigi nel 1947, l’anno prima della fondazione dello Stato d’Israele. Ha origini polacche e svolge la professione di psicoanalista a Milano; le sue conferenze sono seguitissime. Proviene da una famiglia che ha subito le persecuzioni naziste. Il padre, insieme ad altri tre, riuscì a scappare dal ghetto assediato dai tedeschi.
Che cosa accadde esattamente nel ghetto di Varsavia?
«Era il 22 aprile del 1943. Papà fuggì attraverso le fogne e sbucò dal tombino che il suo migliore amico gli aveva indicato. Lo aveva venduto. Trovò i nazisti ad attenderlo. Lo caricarono su un camion e lo spedirono ad Auschwitz. Fu tra i pochi a uscirne vivo».
Tutto questo come e quanto ha pesato nell’ambito familiare?
«Per rispondere dovrei dividere le sensazioni provate durante l’infanzia con quelle della consapevolezza. Ho perfino creduto che mio padre si fosse salvato per ragioni disdicevoli, che avesse collaborato con l’aguzzino. Forse perché restò per anni come muto e non capii che quel silenzio parlava del suo cuore straziato, non di viltà mai accadute. Ma la mia grande domanda restava un’altra».
Quale?
«Quei miei genitori che passarono per Auschwitz come avrebbero potuto continuare a camminare dentro l’ebraismo, dentro la tradizione, dentro tutto ciò che avevano appreso e rispettato? È stata questa la molla che mi ha portato ad essere ciò che nel tempo sono diventato».
Forse non avevano mai perso la fede in quello che avevano imparato ad amare?
«La fede è una parola che ancora mi fa paura e la sostituirei con “fiducia”. Come sono riusciti a non perdere la fiducia? La risposta me la sono un po’ arrangiata, guardando alla tradizione ebraica e alla Torà che è il testo e l’infinito commento del Talmud.
Quando al mio maestro Emmanuel Lévinas chiesero, un po’ malignamente, perché accogliesse un testo eterogeneo come la Bibbia, dove a parlare non era un’unica fonte, lui rispose che occorreva avere fiducia nella Bibbia, in quanto insieme di testi autentici. E ciò che è autentico a generare fiducia».
Perché non chiamarla fede?
«Perché la fede può generare fanatismi mentre la fiducia è la prossimità al noi a tutto quello che di bene questo noi può generare»
Ma può anche disattendere.
«Certo, ed è per questo che il noi non può separarsi dalla tradizione, che va cercata non tanto nella memoria storica quanto nella memoria strutturante, quella che definisce l’identità di un popolo e che consente di sopravvivere alle peggiori prove».
La memoria costruisce un’identità ed esclude la storia?
«La storia, in un certo senso, perde di importanza se letta con le lenti della Bibbia. I giorni
raccontati dalla Torà, non sono giorni storici, il tempo si restringe o si dilata senza un vero punto di
discrimine».
Eppure la Creazione avvenne in sei giorni.
È vero, ma il giorno importante e senza storia è il settimo. La storia ci dice che possiamo
raccontare di noi, delle nostre vicende, del nostro ambiente. Ci dice ciò che è politico, sociale,
psicologico. Ed è la storia dei sei giorni, appunto».
Poi c’è il settimo in cui Dio riposa.
«Al termine dei sei giorni Elhoìm si ritira nel suo Shabbàt e lui fa sì che quel ritiro sia una
benedizione non una maledizione».
Non capisco.
«Un mondo senza Dio sarebbe normalmente una maledizione. Ma lui ha fatto in modo che questo
mondo, effettivamente per noi senza Dio, fosse una benedizione. Cioè siamo liberi di comprendere
la complessità del mondo nel quale viviamo. Lo Shabbàt è un’astensione che fonda la libertà
dell’uomo, perché permette all’uomo di capire dove vive e come può vivere. Alla domanda perché
Dio si è ritirato occorre aggiungerne un’altra: dove? Lui vive nella Torà. Da una parte ci sono
consegnate le scienze e le conoscenze che ci raccontano del nostro mondo e dall’altra parte ci è data
la Torà che parla di un Creatore».
Qual è la differenza importante tra Torà e Talmud?
«La Torà è il come la si è scritta, il Talmud è la Torà come la si legge. Il Talmud è una discussione
infinita tra maestri. Una discussione che a volte sembra sconclusionata. Ma non lo è. I Maestri si
affrontano sia dal punto di vista della coerenza logica che da quello della tradizione e la discussione
può essere se non violenta, decisa e perfino insultante. Il Talmud è il commento alla Torà. Ma la
Torà, per la tradizione ebraica preesiste alla Creazione».
Il “verbo” che viene prima di tutto. Ma di quale verbo o parola si tratta?
«Nella Mishnà — la parte più antica del Talmud — si parla delle dieci cose che furono create alla
vigilia del Sabato tra giorno e notte. Sono oggetti che la parola crea, ma anche dieci modi di pensare
con cui l’ebraismo ha ricondotto e affrontato la complessità del mondo. È di questa parola che si
tratta».
Sono anche i dieci comandamenti?
«In un certo senso le dieci cose ne sono l’anticipazione. I maestri della Cabalà parlano di “esilio del
dire”. I dieci dire della Creazione usciranno dal loro esilio soltanto quando si trasformeranno nelle
dieci parole-cose del monte Sinai, cioè nei Dieci Comandamenti».
In tutto questo che posto occupa l’uomo?
«Quello che gli spetta. Noi uomini non siamo creatori, entriamo sul palco del pensiero un attimo
dopo, alla ricerca del progetto. C’è prima la parola che prescinde dall’uomo e poi viene la
realizzazione e la collocazione nel tempo. È difficile da comprendere e da accettare ma la parola
dell’uomo non crea, anche se noi lo crediamo. Nel testo biblico c’è questo dire e poi c’è tutto quello
che segue».
In tutto quello che segue c’è l’impronta umana.
«Come si relaziona con quello che è venuto prima? Nel Kohelet re Salomone dice: esistono
saggezze esterne — è questo il nome che egli dà alle varie scienze — che ci permettono di capire,
ed esiste una saggezza interiore — che è la Torà — che ci permette di capire. E queste due
comprensioni stanno insieme senza nessuna contrapposizione. O meglio numerose sono le
contraddizioni, come sempre, tra l’interiorità e l’esteriorità, bisogna solo farle coesistere. E questo è
l’incessante opera dell’interpretazione. Solo se sapremo far coesistere queste contraddizioni ci
potremo ritenere liberi».
In una precedente conversazione, che risale a molti anni fa, lei ha indicato in un personaggio
misterioso l’insegnamento più autentico ricevuto. Tutta questa costruzione è da lì che
proviene?
«Lei allude a Monsieur Chouchani. Di lui ho lungamente parlato in un precedente libro, mettendo a
fuoco quello che io ritengo sia stato il suo insegnamento. Oltretutto segnato dal singolare rapporto
che personalmente ebbi con lui».
Intende dire un rapporto diretto?
«Mio padre lo ospitò per qualche settimana quando abitavamo a Parigi. Avrò avuto sette o otto anni
e si presentò quest’uomo vestito umilmente. Mio padre mi pregò di offrirgli la mia stanza per tutto
il tempo che Monsieur Chouchani si fosse fermato. E fu così che ebbi i primi contatti. Non era un
rabbino. Credo fosse qualcosa di più e di diverso, come qualcuno di cui si attende l’arrivo. Aveva
un’immensa cultura e un modo di fare scabro, essenziale, magnetico. Molti dei grandi nomi del
pensiero ebraico, tra cui Lévinas, dissero di avere appreso da lui. Chouchani sparì senza lasciare
traccia. Qualcuno disse di averlo incrociato a Montevideo, qualcun altro che avesse continuato il
suo pellegrinaggio europeo. Ma so una cosa».
Quale?
«Ho immaginato che abbia riunito quei quattro fuggiaschi, tra cui mio padre, per testimoniare
qualcosa di profondamente autentico. A ciascuno di loro fu recapitata una lettera in cui si dava un
appuntamento e quelli, dopo quaranta giorni, si presentarono. In quegli anni erano diventati uomini
ricchi e importanti. Erano usciti da una fogna e si erano guadagnati il mondo. E quando finalmente
giunsero nella sinagoga li accolse quest’uomo che tenne loro l’ultima lezione. C’erano anche poco
distanti due giovani seduti. Il maestro disse che erano figli di scampati e che li aveva convocati
perché testimoniassero con la loro semplice presenza cosa vuol dire aver fiducia. Poi, agganciandosi
alla parola “fiducia”, non fede, ma fiducia, spiegò il senso per cui ad anni di distanza quei quattro,
anche loro sopravvissuti, avevano deciso di affrontare quell’ultimo incontro».
Qual era il motivo?
«Un motivo umanissimo che mi riferì mio padre.
Monsieur Chouchani parlò della fiducia e della forza che restano in noi affinché non si disperdano
nella realtà, non inseguano fantasmi. Disse che fiducia e forza non nascono dalle religioni, dai
martiri, dalle false dimore. Fiducia e forza non hanno casa perché sono in esilio nella nostra
interiorità. E sono intimamente connesse all’essere umano. Questa fu la lezione, che egli arricchì
con il principio della claudicanza».
Cosa indica questo principio?
«È l’imperfezione come eterna perfettibilità. Non la ricerca della perfezione, non l’inseguire il
successo a tutti i costi, ma avere la piena consapevolezza dei nostri limiti, del fatto che siamo esseri
finiti, destinati a errare».
Dove finisce la realtà e dove comincia l’immaginazione nel suo racconto?
«Senza l’immaginazione non esisterebbero le grandi opere poetiche, non esisterebbe neppure la
Bibbia. Congiungere realtà e immaginazione, esterno ed interno è stato cercare un nuovo punto di
equilibrio e quindi un punto più avanzato di saggezza. Per questo ho immaginato che quei quattro
fuggiaschi scappati alla schiavitù del ghetto, come gli ebrei di Egitto, trovassero alla fine di quel
lungo tunnel sotterraneo non i nazisti ad attenderli per condurli ad Auschwitz ma nientemeno che
Israele nell’anno della fondazione, cioè il 1948. L’immaginazione può rompere gli schemi di tempo
e spazio».
E questa Israele è da lei simbolizzata dal “cappello scemo”.
«Non è offensivo. Il kova tembel era in quegli anni un copricapo molto comune, una specie di
berretto del pescatore. Era di tela e veniva indossato per impedire che il sole arrostisse molte di
quelle teste acerbe. Il kova tembel divenne un segno di riconoscimento per chi lo portava. E
vennero da tutto il mondo per realizzare il sogno folle di costruire in pochi anni una nazione nel
deserto. Oggi quel cappello non lo indossa quasi più nessuno e io stesso ho smesso di portarlo. I
cappelli sono diventati una cosa seria».
Certi oggetti segnano la storia di un popolo.
«Per me il kova tembel, il cappello scemo, rappresenta sopra ogni cosa i valori dell’inizio, la
memoria di quando scegliemmo di parlare. Parlammo e quel cappello matto ci fece sembrare tutti
un po’ improbabili, claudicanti e per questo umani».
