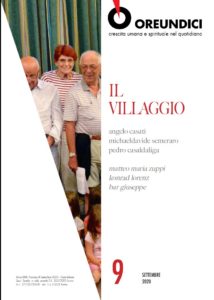
ATMOSFERA DI COMUNITÀ
piccole dimensioni, senza mura intorno
Il sabato del villaggio e lo scemo del villaggio. Sono le prime due associazioni che mi sono venute alla mente a partire dalla parola villaggio. Ho riletto la poesia di Leopardi e poi ho cercato l’etimologia della parola. E sono emersi alcuni aspetti interessanti. Villaggio è un luogo non circondato da mura (etimo.it), è la residenza di una popolazione che ha nelle vicinanze il luogo del proprio lavoro (treccani.it), è un centro abitato di dimensioni limitate, strutturato in modo da rispondere alle esigenze di una particolare categoria di persone, ad esempio studenti o atleti (dizionariointernazionale.it).
Ho pensato che le fortificazioni venivano costruite per difendere un centro dagli assalti e per proteggerne le ricchezze, e dedotto che i villaggi non dovevano essere luoghi ambìti da quanti avessero brama di conquiste.
Ma è bello scoprire che l’etimo della parola villaggio richiami innanzitutto questa assenza di protezioni e quindi, a contrario, la vulnerabilità dell’abitato. Un villaggio non è un luogo chiuso, vi si circola liberamente, si entra e si esce senza dover varcare confini, senza chiedere permesso. Senza mura, però, gli abitanti possono sentirsi esposti a rischi, non solo di aggressioni ma anche di contaminazioni. E non penso ai contagi di malattie (il primo inevitabile pensiero dei nostri giorni), ma al contagio delle culture, dei costumi, delle lingue, degli odori, dei cibi, dei colori. Perché il villaggio – almeno nelle sue origini e nella memoria di coloro che vi sono nati e cresciuti – non è un luogo indistinto, presenta precise caratteristiche: è un centro abitato di dimensioni limitate, ospita una popolazione che lì – o nelle vicinanze – svolge il proprio lavoro. Questo accadeva in tanti piccoli borghi delle province italiane, il cui tessuto era solido e omogeneo, ma che oggi spesso risulta slabbrato, deformato, reso quasi irriconoscibile da generazioni nuove e diverse, approdate lì per destino o per casualità. Solo uomini straordinari come don Milani o Mimmo Lucano sembrano in grado di trasformarli in comunità di vita e di lavoro, di integrare le diversità, il vecchio con il nuovo, di farvi entrare il respiro alto della cultura, della fede (religiosa o laica che sia), dello spirito creativo.
Allo stesso tempo mi vengono in mente alcuni borghi a lungo abbandonati – ne conosco alcuni nell’entroterra ligure e toscano, ma ce ne sono certamente altrove – che hanno ripreso vita negli ultimi decenni grazie all’iniziativa di artisti o agricoltori o artigiani che si sono trasferiti ad abitare lì, avvertendo il fascino dell’antico e/o il profumo di un futuro possibile. Normalmente in questi antichi borghi resuscitati si respira un’atmosfera di comunità, viene facile dare il tu a chiunque si incontri, viene spontaneo il desiderio di conoscere il racconto di quei luoghi, il sogno che li ha fatti rinascere. Ci si sente a casa, il tempo si dilata e gli occhi si posano su particolari normalmente trascurati, che appaiono come insoliti e originali anche quando non lo sono. Si coglie una sorta di omogeneità, un filo conduttore che tiene insieme le case, le persone, i gatti, i vasi fioriti, le attività artigianali, le stradine sempre strette e spesso impervie. Viene da pensare allora che il villaggio sia un’entità, non un agglomerato e neppure una somma di cose e persone. Il villaggio assume una fisionomia, un’identità, una storia.
Qualcosa di simile si sperimenta anche in ambito religioso. A Camaldoli, poco distante dal monastero, si trova la collina con gli eremi in cui vivono i monaci eremiti. Ognuno ha il proprio piccolo orto, una recinzione che lo delimita, tutti convergono verso la chiesa e verso il refettorio per il pasto festivo in comune. È un esempio, millenario ma ancora vivo, di villaggio monastico, nel quale i residenti non solo svolgono la stessa attività, ma vivono seguendo la stessa regola, gli stessi orari, le stesse obbedienze. Ma allo stesso tempo dispongono di uno spazio personale, intimo, libero nel quale rispondono di se stessi unicamente davanti a Dio. Il dialogo tra individuo e comunità avviene all’interno del villaggio degli eremi, strutturato in modo da consentire una misura il più possibile giusta tra le esigenze dei singoli e quelle della comunità.
Tante altre esperienze di “villaggio” sono sorte e si sono sviluppate nel mondo religioso, da Nomadelfia all’Isolotto, per venire incontro all’esigenza di alcuni di vivere una spiritualità concreta, solidale, condivisa nel quotidiano. Spesso, non sempre naturalmente, restano invischiate nella necessità di regolamentare, strutturare, definire “linee guida” di comportamenti, forse necessarie, ma che inevitabilmente spengono la spontaneità e condizionano le libertà. È per questo che il fascino e l’attrattiva di questi luoghi, quasi sempre, si esauriscono con la generazione di coloro che li hanno pensati, voluti, vissuti. Visitarli lascia frequentemente l’impressione del museo che conserva qualcosa di prezioso ma che non è riproducibile.
A mio parere, per concludere, il villaggio è un sogno, il sogno di chi lo concepisce e di quanti lo condividono. Alle volte i sogni diventano realtà, altre volte rimangono immagini ricorrenti – proprio come quelle di certi sogni – inseguite come un’intuizione fascinosa. Ma il villaggio può anche essere una realtà, non sempre rosea e desiderabile come nei sogni. E, in questi casi, può anche accadere che la realtà si trasformi in sogno.
